30 giugno 2019
Quando si parla di omosessualità, molto spesso si associa un concetto, un valore che presumibilmente dovrebbe essere espresso dalla parola “orgoglio”. I giornalisti, che per natura sono dipendenti dalle scorciatoie espressive e dunque sempre inclini all’uso di etichette e luoghi comuni, corroborano tale associazione al punto che statisticamente omosessualità e orgoglio sono connessi come Murano e Burano, muschi e licheni, Inter e Milan e così via. Ma resta la domanda, mai banale, perché l’omosessualità necessita di orgoglio? Che relazione esiste tra i due termini? Che funzione svolge sul piano sociale e comunicativo? E, infine, siamo sicuri che questa associazione faccia del bene agli obiettivi socio-culturali di un movimento che sostanzialmente dovrebbe essere di rivendicazione di pari diritti e dignità? (e qui uso temporaneamente il termine “dignità”, a mia volta per esigenze di immediatezza esplicativa).
Come sempre partiamo dalle cose dure, concrete, che si toccano, che pesano e che restano: le parole (perché aveva ragione Carlo Levi). Mi è d’obbligo precisare che non esprimerò una posizione personale pro o contro, tenterò invece di compiere una analisi che faccia un po’ di luce su un aspetto culturale e sociale che genera sempre contrapposizioni e false prese di posizione, tutte abbastanza inconsapevoli e per niente lucide sia da parte dei sostenitori che dei detrattori delle manifestazioni che celebrano l’omosessualità. Orgoglio è un termine che fin dalla sua nascita presenta caratteristiche che inducono alla cautela. Si tratta, infatti, di una forma nata nell’ambito di quella cultura franco-tedesca i cui sotterranei prolungamenti sono ancora oggi un ostacolo ad un reale processo di integrazione in Europa. L’etimo della parola viene ricondotto al franco “urgoli” e al tedesco “urguol”. La parola è composta dalla particella “ur” – che pare corrisponda al latino “ex” – e dalla parola “guol” che significherebbe qualcosa come il nostro aggettivo “petulante” o anche “lussureggiante”.
Osservo di sfuggita quanta singolare coincidenza ci sia tra la parola “lussureggiante” e le forme che si sono radicate nel mondo per la celebrazione delle giornate dedicate a ciò che si definisce “orgoglio omosessuale”. E per forma intendo i costumi lussureggianti, l’esposizione lussureggiante della nudità, la lussureggiante attenzione dei media, etc. Persino le parole dei rappresentanti istituzionali e, soprattutto, di quella teatrale categoria che sono ormai gli esponenti dei partiti e delle organizzazioni che ruotano intorno al potere, che risultano sempre altisonanti, lussureggianti per obbedienza a fini ed interessi che non appaiono e non risultano mai disinteressati, né equilibrati, né ponderati, ma solo esibiti (ovvero esposti, mostrati), appunto, per lanciare con lussureggiante altisonanza (mi si conceda il neologismo), parole-esca da cui sperare una pesca fruttuosa in termini elettorali.
Ma seguiamo il significato originario della parola orgoglio associato al termine “petulante”. Prestando fede all’origine storica che ha determinato l’esistenza stessa dell’orgoglio (senza la sua dimensione fono-materica, esisterebbe questa forma affettiva che chiamiamo orgoglio?), la qualità di chi è petulante, non rientra propriamente in nessun recinto semantico collegato a qualche nozione di virtù. Il concetto stesso di petulanza (la cui forma mi ha ispirato il neologismo della altisonanza) si porta dietro un fardello decisamente negativo. Secondo quanto riportato nella Treccani, si tratta di un “atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua”. Che descriverebbe comodamente la sensazione ricavata da quanti esprimono disappunto nei riguardi di manifestazioni, compresa quella dell’orgoglio omosessuale ma il riferimento è estendibile agli scioperi che rivendicano forme di “dignità” lavorativa e altri, che risultano quanto meno invadenti dello spazio comune che, ovviamente, non è quello fisico della città destinato al corteo, ma quello emotivo della cultura condivisa. Che, appunto, si rivela non essere così condivisa o, almeno, non del tutto e non per tutto.
In sostanza, in un tempo in cui ciò che alcuni seguono a definire il “fenomeno della omosessualità”, risulta ormai definitivamente entrato nell’orizzonte culturale di tanti paesi, soprattutto occidentali, il richiamo all’orgoglio che mi pare rischi di essere un errore strategico che ottiene l’effetto opposto di quel che dichiara. Orgoglio, infatti, richiama in tutti l’idea di una forza sentimentale che si chiude nella propria identità per fronteggiare un pericolo proveniente da una dimensione esterna. Non a caso, uno dei rarissimi significati positivi che è possibile associare alla parola orgoglio, è quello che parla di “orgoglio nazionale”. L’esempio storico più “lussureggiante” della nostra vicenda di Nazione, è certamente quello del Piave. Ma a parte questa modalità, l’orgoglio è in generale un alibi per procurare dolore e sofferenza, che avvenga in modo preordinato (orgoglio politico) o casuale (orgoglio ferito).
Proclamare la giornata dell’orgoglio omosessuale, secondo questo ragionamento e osservando le dinamiche culturali che mette in gioco, significa “invadere con arroganza” lo spazio (esteriore ed interiore) che è anche di altri, imporre un tempo di attenzione esclusivamente dedicato e concentrato su se stessi. Una versione apparentemente legittima del rovesciamento carnascialesco che permette, semel in anno, di bruciare il totem dei Signori ma per riaffermarne la supremazia per tutto il resto dell’anno. Una manifestazione dedicata all’orgoglio omosessuale risulta quindi capace di far tirare un sospiro di sollievo a chi non ne condivide nulla e spinge i suoi sostenitori a ritornare serenamente dentro quei margini un po’ nascosti dai quali sono come risorti simbolicamente solo per un giorno. Con viva soddisfazione di chi, volendone contrastare la presenza, ha ormai compreso che è sufficiente sopportarli per un giorno per tornare a ignorarli per il resto dell’anno. Non ho mai conosciuto nessuno che dopo una giornata trascorsa, per caso o no, seguendo le celebrazioni degli omosessuali, si sia poi convertito a qualche forma di maggiore sensibilità o vicinanza nei confronti di un gruppo umano di cui non importa quantificare la consistenza. Altro aspetto del tutto inutile a cui sento spesso far riferimento come se il tema si dovesse imporre perché “ormai sono tanti”. Una autentica assurdità, una clamorosa sciocchezza.
Se l’omosessualità è una forma di vivere che si pone come una delle possibilità esistenti, non è dato comprendere per quale fine si debbano perpetuare forme di apparente difesa della categoria che vanno invece nella direzione del contrasto aperto e manifesto, della lotta frontale, dell’invasione di campi altrui. Vi è una contraddizione in termini che mi pare evidente. Come può un gruppo, accomunato da un interesse specifico, chiedere autonomia di spazi mentre contemporaneamente invade gli spazi degli altri? Più che una rivendicazione appare come una richiesta del proprio turno per esercitare a sua volta le proprie intolleranze, ingiustizie, discriminazioni. Basterebbe pensare alle difficoltà che vivono quanti cercano una strada in “mondi sociali” che sono tradizionalmente gestiti e sorretti dalla comunità gay. Le dinamiche umane, le incoerenze dalle quali sorgono ingiustizie, prepotenze e sopraffazioni, non conoscono, esse no, barriere e sono trasversali. Ovunque vi sia preponderanza di un gruppo, di genere o no, vi è una forma di discriminazione nei confronti degli “altri”. In tal senso mi fanno sorridere le illusioni, statistiche alla mano, di chi ritiene che un genere sia migliore dell’altro. Se non vivessimo un’epoca ancora primitiva delle relazioni umane (lo ripete sempre Morin che non a caso sottolinea il concetto di antropocene per evidenziare la centralità tragica dell’Uomo nella caratterizzazione di questo periodo della storia della Terra), avremmo certo già superato i problemi discriminatori e le feste di qualsiasi “orgoglio”.
Quello che ancora trovo singolare è la totale assenza di consapevolezza da parte di chi partecipa a questa espressione festiva del proprio orgoglio di genere. A parte che da festeggiare mi pare ci sia abbastanza poco. E a parte che tali festeggiamenti sembrano non tenere conto dell’unico importante dato ormai saldamente acquisito che è quello dell’esistenza riconosciuta e diffusa e, soprattutto, libera di un terzo genere che a me pare la più forte ed importante affermazione del “principio del terzo incluso” che definisce il mio pensiero e anche la mia attività di educatore di orientamento transdisciplinare. L’accettazione sul piano sociale del terzo genere ha finora generato prevalentemente posizioni di rendita da parte di personaggi che vi hanno intravisto un trampolino di lancio o un contenitore di voti per fini che sono direttamente connessi alla gestione del potere. In realtà a me pare che il valore della presenza della comunità gay stia nel fatto che concretamente, connettendosi al piano relazionale di ogni società dove è liberamente concesso di vivere la propria sessualità senza forzature, si forma una dimensione umana che ospita di fatto ciò che fino a poco tempo fa era considerato con gli occhi della logica aristotelica un terzo da escludere. Un evento non previsto che si collocava fuori della logica binaria che ha prevalso fino a tempi recentissimi, almeno fino all’apparire dell’epistemologia della scuola di Vienna che ha invece iniziato a mettere in discussione quello scientismo che è stato, da Newton in poi, il “potere gestionale” con cui la logica ha governato dovunque, nelle menti delle persone come delle società. Da allora si sono moltiplicati i pensatori che hanno spinto ad una riconsiderazione degli orizzonti della logica. Come già avvenuto per la invenzione di altre geometrie che si sono distanziate da quella euclidea (sulle cui idee abbiamo costruito la nostra rappresentazione del mondo e delle sue leggi), almeno a partire dalla scoperta dello spazio curvo (la Relatività di Einstein) che ha quindi spinto alla ricerca di altre forme.
Siamo abituati all’idea che le nuove scoperte siano e debbano essere frutto della scienza e della tecnica. Dimentichiamo che siamo sostanzialmente uomini e che tutto ciò che produciamo nasce nella dimensione della nostra irrinunciabile umanità. Restiamo umani, fatti cioè della stessa sostanza (anche del Padre, per chi vuole), persino quando facciamo scelte diverse in ordine al modo di vivere la nostra sessualità. E per tale ragione dovremmo sempre muoverci con medesime priorità. Aspetto che appare molto dietro le quinte in fenomeni, questi sì, come l’immigrazione dove pare che l’Europa, per citare orizzonti a me vicini, reciti un po’ a soggetto. La realtà, a mio giudizio, è che la società umana intesa come comunità di destino (anche in questo caso è illuminante il pensiero di Morin che raccoglie e organizza con nuova originalità tante istanze emerse da altri pensatori di svariati campi), è lo “spazio” concreto in cui ogni individuo dà e riceve un contributo che influenza a sua volta tutta la comunità. Magnifico esempio di “tutto” in relazione alle sue “parti” e viceversa, espressione “emergente” (in senso moriniano) della complessità che ci caratterizza. È da questa dinamica che possiamo attenderci un divenire rassicurante e di crescita delle nostre società, ovviamente pensando al divenire di concezione deleuziana, altrimenti resteremmo di fronte a quelle logiche di potere, ancora in atto, che sono sorte dalle interpretazioni del pensiero di Nietzsche. In questa prospettiva trovo singolare, ma non mi stupisce, che le rivendicazioni del cosiddetto “mondo omosessuale” non abbiano trovato un termine più adatto dell’orgoglio per svolgere il proprio compito di riequilibrare, in meglio, l’intera società e non solo se stessi. Non è l’eccesso di enfasi, la smodatezza rituale, l’egocentrismo festivo con cui si celebrano le giornate dell’orgoglio che aiuterà l’affermazione definitiva – nelle forme in cui io le auspico, ovvero di riassestamento complessivo dell’equilibrio di ogni organizzazione sociale inteso come intrinseco miglioramento verso un livello superiore di umanità – delle organizzazioni sociali che sappiano veramente includere tutte le proprie componenti, compresa quella che si riconosce per una scelta sessuale. Sarà piuttosto una ricerca costante e non episodica di “dignità” – e non di “orgoglio” – a far emergere/consentire che gli elementi di una medesima organizzazione si tengano insieme producendo un “tutto” di livello migliore.
Anche qui risulta illuminante la ricerca delle origini del termine: dignità, infatti, pur provenendo dal latino dignus, ossia “degno”, si porta con sé il precedente greco di “ἀξίωμα” che conteneva sia il significato di dignus, che di “assioma”. Ora, è noto che quest’ultimo termine indichi un principio, un principio che racchiude o da cui discende una verità, qualcosa, insomma, la cui sola presenza esprime una verità non sottoposta a verifica, vera di per sé, evidente (che si vede di per sé). In questo modo, con la parola dignità si mettono insieme, strategicamente, sia quell’idea di “condizione nobile”, cioè degna, tipica (o almeno che dovrebbe essere tipica) dell’Uomo, sia la sua evidenza di principio che non ha bisogno di nulla per essere ritenuta vera e dunque ineluttabile, non rinviabile, non opponibile. Tutte caratteristiche che sfuggono (ma aiuterebbero) a chi si batte per l’affermazione sociale della omosessualità. La lotta sociale e culturale, per concludere, dovrebbe prendere una direzione, per così dire, kantiana, nel semplice senso che dovrebbero divenire “assiomi dell’intuizione” (oltre ai concetti di spazio e tempo di cui parla il filosofo tedesco), taluni concetti fondamentali della convivenza civile, quale quello della scelta della propria identità sessuale. Sempre in termini banalmente kantiani, dovremmo cioè saper raggiungere un livello capace di consegnare a chiunque una sorta di “giudizio a priori” che invece di produrre – come accade oggi – una idea di alterità diffidente sostenuta da un orgoglio identitario – fosse capace di diffondere una idea di complessità inclusiva, dalla quale discenderebbe, stavolta sì, un mondo migliore di cui non possono farsi carico, per semplice e passeggera condizione anagrafica, i giovani di ogni generazione. La dignità di ogni essere umano vivente, infatti, è tale che gli è dovuta a prescindere se sia uomo o donna, etero o omosessuale, residente o migrante persino (aggiungerei almeno quest’altra disdicevole questione che dimostra il grado primitivo delle nostre competenze relazionali).
Alla tirata dei conti, per esser chiari, vedrei con maggiori possibilità di successo concreto una giornata mondiale della “dignità omosessuale” che prendesse il posto dell’attuale, inutile e controproducente orgoglio. Il passaggio, però, dovrebbe avvenire con la lucidità che ho cercato di esporre, cercando cioè di far divenire quel sentimento sgradevole, sempre esposto al rischio dell’oltre senza ritorno, che è racchiuso nella storia e nella cronaca della parola orgoglio, un sentimento di dignità. Va cioè inteso che dove c’è orgoglio, c’è rivendicazione di identità chiusa in se stessa, impermeabile alla creazione e al mantenimento di relazioni con un intorno dal quale ci si isola per effetto stesso dell’orgoglio, al massimo è consentito che le relazioni si mantengano senza interferire con quel blocco di compattezza che l’orgoglio rivendica e definisce. Ovviamente ci riferiamo ad una realtà che sfugge ad ogni compromesso, ad ogni movimento di avvicinamento verso altre identità, altri orgogli, con ciò statuendo l’impossibilità di un oltre condiviso. Paradossalmente, laddove vi sia rivendicazione di orgoglio, dunque, come ragione di vita e sopravvivenza, contemporaneamente si ha affermazione e rivendicazione di una condizione di stasi, di assenza di movimento e di negazione di relazione, che è un’altra dimensione del movimento, anch’essa negata. Ma dove c’è assenza e negazione di movimento non può esserci vita, così l’orgoglio rivela la sua natura mortifera, esattamente l’opposto di ciò che predica. Al contrario accade per il concetto di dignità che è bene leggere alla luce del concetto di divenire che ci fornisce Deleuze quando parla del divenire nel mezzo. La dignità, cioè, è una dimensione potenzialmente aperta dentro la quale ciascuno può entrare, uno spazio concettuale che ciascuno è in grado di rivendicare per sé e per il proprio gruppo nel quale si riconosce. Per tale ragione, in questo regno di mezzo si incontrano teorie e pensieri diversi che, della dignità appunto, fanno terreno di mutuo scambio. Intorno al concetto di dignità dunque, esiste un universo di relazioni ed intrecci che fanno da sfondo a ciò che ciascuno ritiene il fuoco della propria attenzione riguardo alla dignità. Da questo tessuto di relazioni nascono ulteriori intrecci e nuove relazioni si istituiscono, per semplice osmosi o per effetto di nuovi ingressi, come ogni organizzazione concettuale, anche quella che qui consideriamo è soggetta a spostamenti e ricerca di nuovi equilibri. Il concetto in se stesso accoglie tutto e raccoglie tutti, salvo che, successivamente, ciascuno dopo essere entrato nel concetto di dignità con un proprio bagaglio, ne esce con uno in qualche misura diverso, per effetto delle relazioni che ha dovuto intessere per rapportarsi al proprio concetto stesso di dignità. Certo, si può uscire da questo universo di relazioni con una posizione di netto rifiuto di tutto ciò che non corrisponde alla propria fisionomia, ma resta il fatto che chi decide di chiudersi in un solo modello di dignità alquanto ristretto, conosce contemporaneamente il contenuto degli altri possibili modelli. Per ciò stesso, dunque, si nutre della differenza più che della propria identità, la presenza dell’ “altro”, cioè, gli è necessaria ancor più che della presenza del sé medesimo. Ed è evidente come tutto ciò sia frutto di un intrinseco movimento che, come detto prima, è la forma della vita, di ciò che vive e che non può essere statico, come accade per l’orgoglio. Ebbene questo spazio comune dove ogni particolare concetto di dignità si insinua e crea relazioni necessarie, è appunto quel “mezzo” che caratterizza il divenire di Deleuze. La propria visione di dignità, in sostanza, si calibra attraverso l’incontro, scontro e confronto con le altre visioni della dignità. Ciò non significa che la dignità di un individuo o di un gruppo si trasformi in quella dell’altro, ma che per sostenere la propria visione di dignità occorre pensarla con la prospettiva delle altre visioni, progettare la propria idea di dignità comporta uno sforzo previsionale nei termini dell’altrui visione del medesimo concetto. La radice della parola stessa dignità, come si è già richiamato, spiega questa particolarità dato che un assioma non è che un punto di partenza necessario per costruire un quadro teorico e, come tale, è principio di movimento. A differenza della natura petulante del concetto di orgoglio che nega il movimento in quanto ripetizione sempre uguale a se stessa che fa dell’insistenza, sua specifica forma di movimento, la propria cifra e che è sostanzialmente un battere sul punto, senza aprire né consentire l’avvio di un qualsiasi movimento.
La rivendicazione di un orgoglio, per concludere in termini figurativi, è come l’azione del battere con un martello su un chiodo già piantato. Per l’analisi psicologica, infatti, è materia dell’ego, la parte meno interessata alla “diversità” e dunque all’incontro con un “altro” che sia persona o concetto o luogo o dimensione. L’ego non si muove, gira intorno a se stesso e su di sé sta. La rivendicazione di una dignità, invece, è come segnare con la matita un punto e da lì iniziare il proprio disegno. In chiave psicologica, tratta della profondità dell’ “essere”, un luogo della personalità che sta in un fondo da cui emerge e per ciò stesso richiede un movimento, un avvicinamento, un approssimarsi, un andare e venire. Questa sì dimensione del divenire, del movimento e della possibilità di incontro, scontro, confronto con ogni “altro” con cui sia dato imbattersi.
Perché, dunque, essere orgogliosi dell’omosessualità e non rivendicare invece una propria “dignità”?


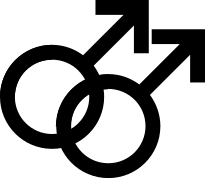
Molto complesso questo pensiero..io credo invece, che la ragione sia molto piu semplice.Dopo una lunga e dolorosa storia di vergogna deila propria reale identidad vissuta socialmente come colpa o malattia ,il riconoscimento della naturalidad delle differenze di genere ha ,per contrappasso, provocato il sentimento opposto ,id l’orgoglio.Lo trovo normale come un rito liberatorio